lunedì 31 maggio 2010
Il nuotatore d'inverno
Racconti di un'unica storia, in cui accanto ai personaggi reali se ne muovono altri fantasma, nel senso di figure fuggite via dalla vita e scomparse, ma a volte anche inesistenti, simulacri o immagini fluttuanti in un paesaggio improbabile e irreale, tutti però accomunati nell'identico destino della loro dolorante umanità.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

























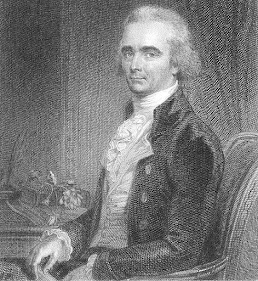






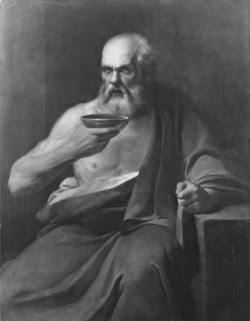

















4 commenti:
IL MORMORIO DELLA MORTE
Avete mai passeggiato in un boulevard del tredicesimo arrondissement di Parigi in un’alba d’inverno? Forse no, non a tutti è capitato di passeggiare in un tale contesto spaziotemporale; più correttamente direi che il termine “tutti” di cui parlo si riferisce a una classe di persone, i non residenti, i turisti in visita nella Ville Lumière o altro genere di visitatori per motivi, diciamo, di lavoro paredro, forma ausiliare e di secondo ordine del lavoro principale, quella sorta di turismo professionale che serve ad unire l’utile al dilettevole (utile dulci), una forma quest’ultima di perfezione del lavoro impiegatizio dirigenziale, di cui sono sacerdotesse dell’età moderna le segretarie per vocazione dall’alto, in questo senso custodi sacre del segreto, poi spesso svelato con strascichi giudiziari, come si addice agli empi violatori delle tavole in pietra della Legge.
In quell’alba d’inverno, io sono uscito sull’avenue d’Italie non come paredro di una qualche superiore divinità professionale, ma come umile (nel mio humus familiare) e chierico (ecclesiaste) viandante della religione dei Lari, gli Spiriti domestici, che vegliano sulla Casa e custodiscono la memoria passata degli antenati nati e non nati, immaginari o immortali questi ultimi a seconda della prospettiva spirituale, di cui ha visione la poetica della rammemorazione.
Era spettrale, nell’incerta luce grigiastra della notte alla fine, la deserta avenue della domenica mattina; ed ora io, nella prospettiva di icone fuggenti all’indietro, verso cui mi volto a guardare, percepisco le emozioni lacerate, proprie dell’esule ritrovatosi oltre il confine, l’elegia della vita che fugge in compagnia del tempo ferito. Sono molti anni che io vado errando insieme con questa figura d’esilio, la cui entità esistenziale si struttura e traspare attraverso requisiti costitutivi irreali.
Nascosto nel museo di Bruxelles, Ross si aggira la notte nelle gallerie e passa lunghe ore a contemplare la debole luce notturna emessa dai bronzi di antica collezione cinese, poi quando in fuga raggiunge New York, si muove nell’alba tra i grattacieli, irreale come le Ombre in Paradiso: “… risalii fino alla quinta avenue tranquilla e quasi deserta. Funzionavano solo i semafori. Tutta la lunga strada diventava rossa o verde in base a una volontà insensata e non più umana… Al di sopra di questo inquietante paesaggio del silenzio, il cielo cominciò lentamente a schiarirsi… La notte si spense, l’ora incerta che precede l’alba si stese sulla via come una nebbia…”
Chi è Ross? Un uomo senza più patria e nome, nella Germania hitleriana, che vive con un passaporto ereditato a Francoforte da un defunto.
Qui, nel tredicesimo arrondissement di Parigi, dove io, dopo due generazioni, mi muovo nell’alba, direbbero un sans papiers, un invisibile in una comunità d’invisibili, quella lunga fittissima schiera dei senza documenti e diritti, un inesistente. Ma, poi, che cosa è un documento, Dorino Oliviero? Io mi nomino, dunque, io ho un nome. Nell’irrealtà dell’alba spettrale, inseguito dalla colpa anonima del vivente la storia dei mortali, non posso pertanto sottrarmi al mio destino di profugo dello spirito, errante oltre la frontiera della fiducia patria, e debbo quindi sottostare e sopportare il carico ricevuto in sorte dal regno dei predecessori.
Io, però, non sono soltanto un quisque Oliviero, invero; sono anche uno scrittore (Dorino Oliviero scrittore?), che deve raccontare la sua storia scandita dal tempo invisibile segnato nel cielo, dove dall’antichità correndo si inseguono gli astri, misura e dimensione del fluire degli avvenimenti cosmici. Il mio debito di narratore, seppure sospetto, per quel dubbio parentetico di sopra, deve espletarsi nella scansione testuale, qui nel suo doppio significato di testimonianza ed ancoraggio ad un testo scritto, del mio tempo individuale, onde lasciarne memoria, documento, traccia. Ecco i miei documenti di sans papiers dello spirito vago e albeggiante nell’avenue d’Italie del tredicesimo arrondissement di Parigi.
Finisce qui? No, la mia anonima storia iniziata qualche giorno fa nella bruma mattutina di una spiaggia della Normandia, una storia ricca di premesse, che affondano le loro radici lontano nel mio tempo dell’anima, percorrendone tutta la profondità, che pure è senza limite, come sapienze oscure ci tramandano nel loro insegnamento non dissolto nei secoli, non è finita. E come avrebbe potuto finire? Così io pongo il mio interrogativo alla dama soluta, quella delle Rosine, dei Santi d’oro e di altre ingannevoli ombre, di cui non è ancora stata scritta l’umana vicenda e chissà se mai in un virtuale domani sarà raccontata!
L’inizio è incerto, nella logica del circolo forse volubile di ogni storia o destino di uomo, che si consuma in quello spazio del calendario, dove sono segnate le date del suo apparire e scomparire nel regno dei contemporanei, quelli che in anonimo stanno e vivono tra i predecessori ed i successori. Ed allora, inseguendo un punto del cerchio, dove fissare l’inizio, io mi ritrovo tra le incostanti allegrie della vuota sala d’aeroporto, nella calma del pomeriggio illuminata dal sole invernale, dove mi è ancora impressa nell’animo la scia splendente del sole rosso del mezzogiorno appena trascorso, una delle fisiche felicità non del tutte smarrite.
Si ripresenta questa felicità, nella fuga dell’assolato meriggio, ogni volta che il sole inonda le stanze della mia casa, la vita piena del giorno di luce che segue il giorno di luce. Noi però, andando in aeroporto, non potevamo seguire la scia del sole, che inesorabilmente volgeva verso destra al divaricare della strada, da una parte in direzione del passato felice, presente nello splendore del sole sull’asfalto sognante, dall’altra nel futuro fascinoso e ordinario del continuo invito a raggiungerlo. Noi non potevamo deviare per quella strada illuminata di luce rosso arancione, perché non era a noi consentito lasciarsi insensatamente abbagliare dai fantasmi splendenti del ricordo, di cui nel presente non si dà possibilità di racconto, in quanto inevitabilmente sorpresi in prospettiva nella coscienza figurata del tempo.
Per spiegare l’improvvisa scelta obbligata, estemporaneo (ex tempore) deve definirsi l’invito del raggio di sole, nella sua curvatura a dritta, un’espressione questa che nella sua formulazione pallidamente pretende di rispecchiare tutta la linearità e ad un tempo la curvatura del tempo, di cui qui non si può che dare una configurazione tangenziale, la tangente che sfugge all’orbita e precipita nel baratro di luce dell’istante subito sparito, un compimento di storie di vita, anodine all’occhio indifferente dell’osservatore imparziale.
In sostanza, vale a dire oltre le forme del mio narrare, era fuori dal tempo consentito, extra tempora ad id statuta, una deviazione impensabile nella striscia di luce dove il sole del meriggio annegava, perché noi dovevamo, io dovevo raggiungere le coste della Normandia, la spiaggia delle nebbie, dove appare il cavaliere galoppante sulla linea del bagnasciuga e sfilano altre inconsistenti spettrali figure. Quindi dovevamo lasciare al margine del tempo, segnato dalla scia di luce del sole, le storie di trascorsi drammi e gioie, le stagioni vissute, che non sparivano nella striscia luminosa, ma si accompagnavano ad essa come impronta memoriale e linea di una traccia sempre inseguita.
Non mi sottraggo ora, io, Dorino Oliviero, al compito di rendere ragione del mio essere ritornato al singolare, dopo essermi sdoppiato al plurale, come ho lasciato intravedere, dicendo: “perché noi dovevamo, io dovevo raggiungere…” In compagnia di chi? Un uomo in compagnia dei suoi fantasmi?
Sull’avenue d’Italie, nell’alba ancora caliginosa, che andava dissolvendo le ombre della notte, nel tredicesimo arrondissement della deserta domenica mattina, io ho di colpo arrestato il mio camminare e sono andato incontro a lei sulla via del ritorno, la dama dell’altro tempo da me, non il tempo dei predecessori e neppure quello dei successori, ma un tempo contrario ad ogni logica di narrazione, perché rende possibile l’incontro tra persone mortali non contemporanee tra loro. In questo senso la mia storia sfugge al mio racconto, io stesso sfuggo ad essa e vengo eclissato, come dire scavalcato, da un nuovo personaggio (o forse antico), di cui qui non viene data ulteriore identità.
“Vous êtes ici?” Ella mi ha domandato, incrociandomi sull’avenue.
Sgrammaticato modo d’interrogare, alquanto diffuso e non solo, ma pure ingombrante nell’attesa della risposta.
“Je suis étranger” ho replicato.
Avrei potuto replicare diversamente?
L’estraneità alla vita che fa dello straniero un esiliato in patria non è però più tale di fronte al fenomeno della morte, di cui egli conserva nella sua ragione lo schema, i tratti generali, tanto per intenderci al di fuori della filosofia di Kant e dei suoi successivi e necessari interpreti. Noi abbiamo lo schema del “cane” in testa, perciò ri-conosciamo un cane per la strada, una sorta di reminiscenza platonica, e così per tutto quello che incontriamo nella nostra esperienza, di cui è già impronta schematica nella nostra mente.
Elena Strano ed il commissario Siracusa erano i morti che io, nella mia identità di Dorino Oliviero alias Mariano Calzino, avevo incontrato o rincontrato nella mia esperienza con il giudice avvocato giurista grecoromano Torricelli, il pallido paraclito di Palati Dikerogoi nel centro storico di Roma, ed in essi, la fascinosa giornalista ed il coraggioso difensore della legge, io riconoscevo il loro status di defunti, perché nella mia mente è scolpito lo schema della mortalità dell’esistenza.
Se noi svuotiamo di tutta la sua concretezza tragica la morte di questi due esseri mortali, che hanno vissuto e sofferto la loro vita in drammi di gioia, stupore, commozione e dolore, che cosa rimane delle loro esistenziali figure, se non il nulla di uno schema vuoto? Se io dunque perdevo il volto di Elena e di Siracusa, il vissuto delle passioni della loro vite non trattenuto e disperso nel vento freddo del pensiero razionale, rendendo anonime quelle vite e quelle morti, rendevo privo di volto e nome anche me stesso.
Questo mi accadeva, perché uscendo dalla mia identità e perdendo il mio nome, diventavo un anonimo contemporaneo che qui così si attesta, dà testimonianza di sé, rivolgendosi a tutta un’anonima classe di mortali, che vive il suo stesso tempo, ma anche lo trascende nella più universale immensità delle celesti evoluzioni nello spazio profondo.
Ora la domanda s’inscrive, non più rinviabile, nel nostro contesto: “Possiamo noi, uomini rivestiti di tutta la nostra dolorante umanità, accontentarci di un algido riferimento alla morte, trascesa dal tempo storico e dal corso degli astri, che ne segnano il calendario? Non sentiamo vicino a noi il soffocato bisbiglio dei defunti, che ci sussurrano il mormorio della morte?”
Come Dorino Oliviero, scrittore che scrive i suoi romanzi sul tempo e sulla morte, devo continuare nella mia opera di narrare, anche se Elena Strano, i capelli smossi leggermente dal vento in cima alle Dolomiti, non c’è più, anche se il commissario Siracusa è scomparso per sempre, con il suo impermeabile bianco macchiato di sangue rosso vermiglio.
È il mormorio dei morti, che dalle anteriorità del tempo vissuto sulla terra, un tempo mortale che invero ha già compiuto il suo corso nel cielo, inviano ai loro successori i suggerimenti per un disegno, dove finiranno per mostrarsi, non è improbabile, altre più cupe figure.
Posta un commento